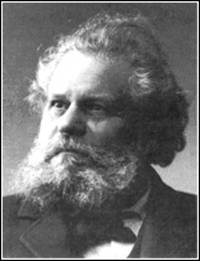L'infanzia
Nacque nel
1835 a Valdicastello (Lucca)
da Michele e Ildegonda Celli, ma nel
1839 la famiglia si trasferì a
Bolgheri, dove il padre
implicato nei
moti carbonari del
'31, esercitava la professione
di
medico condotto. Tra questi
paesaggi, il cui ricordo si riscontrerà in molte delle sue poesie, il
giovane Giosuè trascorse felicemente la propria infanzia fino al
1848, quando il padre dovette
trasferirsi perché accusato di attività antigovernativa. A Bolgheri e a
Castagneto,Carducci intraprese i primi studi e fece le prime letture,
sotto la guida del padre dotato di una buona cultura classica.
Gli studi
Nel
1849 la famiglia si stabilì a
Firenze dove Giòsue compì gli
studi presso gli
Scolopi acquisendo una buona
preparazione in campo letterario e retorico e nel
1853, dopo aver vinto il
concorso per un posto gratuito presso la
Scuola Normale Superiore di Pisa,
si iscrisse alla Facoltà di lettere dove nel
1855 conseguì la laurea con
una tesi sulla
poesia cavalleresca e nello
stesso anno pubblicò le sue prime poesie sul mensile "L'Arpa del
popolo".
L'insegnamento
Nel
1856 dopo essersi trasferito a
Santa Maria a Monte, piccolo borgo nella provincia di
Pisa, insegnò
retorica presso il ginnasio di
San Miniato vivendo una
intensa esperienza che riporterà poi nel
1863 nelle pagine di carattere
autobiografico: Risorse di San
Miniato. Nel corso di questo anno il poeta andò affermando la sua
poetica anti-romantica e con il gruppo di amici formato da
Giuseppe Chiarini (1833-1908),
Ottavio Targioni Tozzetti
(1833-1899),
Tommaso Gargani (1834-1862) ed
Enrico Nencioni (1837-1896) fondò la società letteraria degli Amici
pedanti, dal taglio fortemente
classicistico e
anti-romantico, intervenendo in modo battagliero nelle discussioni tra
manzoniani e anti-manzoniani
ai quali ultimi appartiene.
Nel luglio dello stesso anno ottiene l'abilitazione all'insegnamento, ma
non viene ratificata dal
governo granducale la sua
designazione per concorso al ginnasio di
Arezzo.
Le idee politiche
Sospettato
dalla
polizia per le sue idee
filo-repubblicane, il
9 aprile
1858 venne sospeso
dall'insegnamento e per la durata di tre anni visse a Firenze
guadagnandosi da vivere con il lavoro presso l'editore
Barbera del quale curava l'edizione dei piccoli volumi della "Bibliotechina
Diamante" e dando lezioni private. Negli anni del trasformismo il poeta
conquistò un posto centrale nella stuttura ideologica e culturale
dell'Italia umbertina, giungendo ad abbracciare le idee politiche di
Francesco Crispi.
I lutti
Colpito
nel giro di due anni da due gravi lutti - nel
1857
morì il fratello Dante, morto
suicida nella casa santamariammontese del poeta secondo la versione
ufficiale, ma forse ucciso accidentalmente dal padre dopo un litigio
secondo una più recente versione, e nel
1858 lo stesso padre si
suicidò per il dolore o forse
per il rimorso; entrambi vennero sepolti nel vecchio cimitero del paese
dove oggi sono ancora visibili le lapidi - Carducci trascorse un periodo
di grande sconforto che espresse attraverso alcune sue liriche
ricordando il "colle" ove ebbe luogo la tragedia, ovvero Santa Maria a
Monte, ma nel
1859 il
matrimonio con la cugina
Elvira Manicucci, dalla quale
ebbe quattro figli (Dante, Bice, Laura e Libertà), lo aiutò a superare
il dolore dei lutti. Fu di nuovo colpito da gravi lutti familiari nel
1870 con la morte della madre
e del figlio
Dante, a cui dedicò la poesia
"pianto
antico".
Pianto antico
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| |
« No, non è vero, che è meglio che
sia morto: me lo volevo crescere e educare a
modo mio, doveva sentire, pensare, lottare anche
lui per il bene e per il vero. No, no: scambiare
in sul primo entrar nella vita l’avvenire
dell’esistenza per l’oscurità del non essere non
è bene… » |
| |
|
Pianto antico è una poesia di
Giosuè Carducci dedicata al figlio
Dante. Scritta nel
1871 è il XLII componimento delle
Rime nuove (1887).
I lutti familiari
[modifica]
Il
9 novembre
1870, il piccolo Dante, a soli 3 anni di età, era
morto, molto probabilmente di
tifo, nella casa paterna di via Broccaindosso a
Bologna. Non era infrequente in quei tempi la mortalità
infantile dovuta spesso alle ancora mancate conoscenze
della medicina.[1]
Dante era stato il primo maschio, dopo Beatrice e
Laura, nato dopo il matrimonio di Carducci con Elvira
Menicucci. L'ultima figlia Libertà nascerà nel
1872.[2]
Nel febbraio dello stesso anno
1870 il poeta aveva perso anche la madre Ildegonda
Celli mancandogli in appena nove mesi quella che gli
aveva dato la vita e quello a cui egli l'aveva
trasmessa.
| |
« ...A febbraio la mia povera
mamma; ora il mio bambino; il principio e la
fine della vita e degli affetti. » |
| |
|
Del primo grave lutto così scrisse al fratello:
| |
« Ella riposa, e non sente più
nulla. Pace! Pace! Ma non è finita, non finisce,
non finirà mai, la memoria e il desiderio nostro
di lei. Io, che tutti i giorni quasi e spesso
nei sogni penso e riveggo il nostro fratello
morto, io ricorderò sempre lei, la rivedrò
sempre; la ricorderò, la rivedrò, anche, spero,
all’ultimo punto della mia vita » |
| |
|
Nella lettera sopra citata Carducci accenna ad
un'altra tragica morte («...riveggo il nostro fratello
morto...»): il
suicidio nel
1857 del fratello appena ventenne Dante,[3]
del quale il poeta aveva voluto mantenere il ricordo
proprio nel nome del figlio.
Di questi giovani morti dallo stesso nome e così
vicini Carducci celebrò ancora le vite interrotte
prematuramente nel sonetto Funere mersit acerbo,
scritto poco tempo dopo la morte del figlio.
«È il fanciulletto mio, che a la romita
tua porta batte: ei che nel grande e santo
nome te rinnovava, anch’ei la vita
fugge, o fratel, che a te fu amara tanto.»
(da Rime nuove, XI)
L'albero a cui tendevi
La pargoletta mano,
Il verde melograno
Da' bei vermigli fior
Nel muto orto solingo
Rinverdì tutto or ora,
E giugno lo ristora
Di luce e di calor.
Tu fior de la mia pianta
Percossa e inaridita,
Tu de l'inutil vita
Estremo unico fior,
Sei ne la terra fredda,
Sei ne la terra negra;
Né il sol piú ti rallegra
Né ti risveglia amor.
La
metrica della poesia è quella di una breve
ode in
quartine di
settenari, secondo lo schema ABBC (il quarto verso
sempre C, e sempre tronco).
Il simbolo del melograno
[modifica]
Il pianto del padre è antico come il dolore che gli
uomini di tutti i tempi hanno provato di fronte alla
morte. Emerge dal passato anche la figura del
melograno, antico simbolo di fertilità, di rinascita
e resurrezione.[5]
Questo cespuglio, che al termine dell'inverno appare
secco e arido, tale da sembrare ormai morto, ecco che
invece ricomincia a nascere al calore del sole
primaverile e a mettere quei bei piccoli fiori, di un
rosso intenso come quello del sangue vitale, che la
giovane vita del piccolo Dante invano ha cercato di
afferrare. Il melograno resusciterà a nuova vita non
così il bambino ormai per sempre nella terra fredda e
nera.
Il gioco dei termini usati nella poesia esprimono il
netto contrasto tra la vita ("luce", "calor") e la morte
("pianta... inaridita", "terra fredda", "terra negra")
tanto più dolorosa quando coglie una "pargoletta mano"
non più capace di trattenere nelle sue mani la vita.
Dante era stato l'ultimo, unico frutto, di una
pianta, di quella ormai inutile vita che Carducci sente
non più scorrere in lui: ormai non piange neppure più, è
completamente inaridito perché la sua vita è stata
spezzata dalle radici.
Quel piccolo orto, prima luminoso e sonoro dei rossi
colori del melograno e dei giochi del bimbo ora appare
al poeta troppo silenzioso e solitario ed ormai né il
sole, né l'amore potranno farvi ritornare la vita.
Lo stesso ritmo infine della poesia sembra suggerire
quelle
nenie che si recitano ai bambini per farli
addormentare ma qui non c'è gioco fantastico, vi è
tristezza, rassegnazione profonda: questa è una nenia
per un sonno di morte.
- ^
Così Carducci descrive la morte improvvisa del
figlio:
«Il mio povero bambino mi è morto; morto di un
versamento al cervello. Gli presero alcune
febbri violente, con assopimento; si sveglia a
un tratto la sera del passato giovedì (sono otto
giorni), comincia a gittare orribili grida,
spasmodiche, a tre a tre, come a colpi di
martello, per mezz’ora: poi di nuovo,
assopimento, rotto soltanto dalle smanie della
febbre, da qualche lamento, poi da convulsioni e
paralisi, poi dalla morte, ieri, mercoledì, a
ore due» (lettera di G. Carducci al fratello
Valfredo,
10 novembre
1870).
- ^
Un quinto figlio, Francesco, morì dopo pochi
giorni dalla nascita.
- ^
Suicidatosi secondo la versione ufficiale, ma
forse ucciso accidentalmente dal padre dopo un
litigio secondo una più recente versione (in
Musei di Santa Maria a Monte. Nel
1858 lo stesso padre si
suicidò per il dolore o, forse, per il
rimorso; entrambi vennero sepolti nel
vecchio cimitero del paese, dove oggi sono
ancora visibili le lapidi.
- ^
La fonte principale per l'analisi critica
estetica della poesia è :Storia generale
della Letteratura Italiana, Federico Motta
Editore, Milano 2004, Vol.X pagg.568 e sgg. del
saggio di Raffaele Sirri ivi contenuto.
- ^
Nell'antichità la melagrana era anche simbolo di
fertilità, di nuova vita ma anche, specie
nell'arte rinascimentale italiana, in Donatello,
Michelozzo, Verrocchio, Rossellino ed altri, il
simbolo della melagrana, motivo ornamentale
diffuso anche nella scultura, soprattutto
sepolcrale e nell’architettura classica, era
anche simbolo di morte.
Il ritorno all'insegnamento
Riammesso
all'insegnamento, gli venne affidato un incarico presso il liceo
classico Niccolò Forteguerri di
Pistoia dove insegnò per tutto
il 1859
latino e
greco.
Con
decreto del
26 settembre
1860 venne incaricato,
dall'allora ministro della Pubblica Istruzione
Terenzio Mamiani Della Rovere,
a tenere la cattedra di eloquenza italiana, in seguito chiamata
Letteratura italiana presso l'Università
di Bologna dove rimarrà in carica fino al
1904. Pubblicò nel frattempo
Juvenilia, che raccoglie tutte le poesie del decennio precedente.
Nel
1863 pubblicò con lo
pseudonimo di Enotrio Romano l' Inno a Satana che, pur ottenendo
successo, fomentò vivaci polemiche. Sempre di quell'anno è la
pubblicazione Delle poesie toscane di A. Poliziano.
La poesia laica
La sua
poesia intanto, sotto l'influsso delle
letterature straniere ed in
particolare di quella
francese e
tedesca, divenne sempre più
improntata di
laicismo mentre le sue idee
politiche andavano orientandosi in senso
repubblicano. Oltre all'
Inno a Satana pubblicò nel
1868 la raccolta maggiormente
impegnata dal punto di vista politico: Levia Gravia.
Il legame alla massoneria
Nel
1866 vide la stampa il
saggio Dante e l'età sua e
Carducci divenne segretario della "Felsinea", una
loggia massonica. Il legame
alla massoneria e all'unione democratica gli costò come punizione la
richiesta da parte del ministro
Broglio del trasferimento alla
cattedra di
Letteratura latina di
Napoli, trasferimento che
Carducci rifiutò.
Ottenuta nel 1868 la revoca del trasferimento, venne sospeso
dall'insegnamento per due mesi e gli venne tolto lo
stipendio.
Nel
1870 morirono la madre e il
figlio Dante di soli tre anni lasciandolo in un cupo dolore che cercò di
alleviare con l'intenso lavoro letterario.
Poeta nazionale
Nel
1871 il poeta conobbe
Carolina Cristofori (moglie
dell'ex-garibaldino
Domenico Piva e madre di
Gino Piva), una donna ricca di
ambizioni culturali, con la quale iniziò un fitto scambio epistolare
sfociato nel
1872 in una relazione amorosa.
Alla donna, chiamata Lina o Lidia nelle lettere e in alcune poesie,
dedicherà molti dei suoi versi e fu proprio in questo periodo che la
fama del poeta, come guida nazionale della cultura italiana, si
consolidò. Di questi anni è l'ampia produzione poetica che verrà
raccolta in Rime Nuove (1861-1887)
e in Odi barbare (1877-1889).
Proseguì l'insegnamento universitario
e alla sua scuola si formano personalità come
Giovanni Pascoli,
Severino Ferrari,
Renato Serra,
Alfredo Panzini,
Manara Valgimigli ed
Emma Tettoni[citazione necessaria].
Nel
1873 si recò per la prima
volta a
Roma e pubblicò A proposito di
alcuni giudizi su A. Manzoni e Del rinnovamento letterario d'Italia.
Nel
1878, in occasione di una
visita della famiglia reale a
Bologna, scrisse l'Ode Alla
Regina d'Italia in onore della regina Margherita, ammiratrice dei suoi
versi e venne accusato di essersi convertito alla
monarchia suscitando forti
polemiche da parte dei repubblicani.
Negli anni
che seguirono collaborò con il
giornale "Fanfulla della
Domenica" di impronta filo-governativa (1878), pubblicò le Nuove Odi
Barbare e i Giambi ed epodi, collaborò alla Cronaca bizantina e lesse il
famoso discorso Per la morte di Garibaldi (1882).
Sulla Cronaca bizantina uscirono nel
1883 i
sonetti del Ça ira e nel
1887 pubblicò Rime nuove. Il
corso che tenne all'Università nel
1888 sul
poema
Il giorno di
Parini produsse l'importante
saggio Storia del "Giorno" di G. Parini. Nel
1889, dopo la pubblicazione
della terza edizione delle Odi Barbare, il poeta iniziò ad assemblare
l'edizione delle sue Opere in venti volumi, lavoro che si concluse nel
1899.
La nomina a senatore
Nel
1890 venne nominato
senatore e negli anni del suo
mandato sostenne la
politica di
Crispi , che attuava un
governo di stampo conservatore, anche dopo la
sconfitta di Adua.
Conobbe in quello stesso anno la scrittrice
Annie Vivanti con la quale
instaurò un'intensa
amicizia sentimentale.
Gli ultimi anni di vita
Nel
1899 pubblicò la sua ultima
raccolta di versi, Rime e Ritmi, e nel 1904 fu costretto a lasciare
l'insegnamento per motivi di salute. Nel
1906 l' Accademia di
Svezia gli conferì il
Premio Nobel per la
letteratura, il primo ad un
italiano.
La
morte lo colse a Bologna il 16
febbraio del 1907. È sepolto alla
Certosa di Bologna.